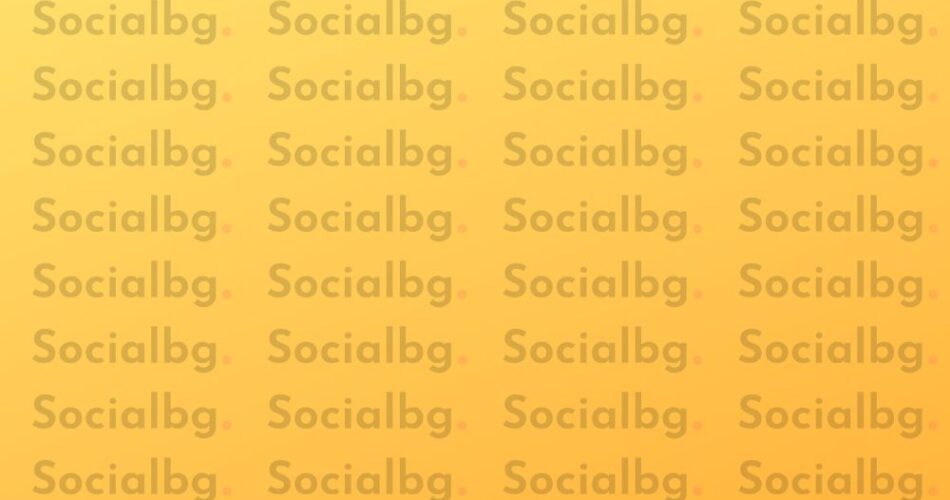Opera giovanile di Platone, Apologia di Socrate è un omaggio al maestro e resoconto di un processo che con gli anni rischiava di sbiadirsi o era raccontato male (Senofonte). Platone qui dà la sua testimonianza senza aggiungere di suo.
Il processo si aprì nel 349 a.C. L’accusa era di non riconoscere gli dei della città anzi di introdurne di nuovi e quella di corrompere i giovani. Il processo fu condotto sotto il governo dei Democratici che erano subentrati alla terribile Tirannia dei Trenta.
Di prassi, per difendersi ci si rivolgeva a scrittori di professione. Socrate mette subito in chiaro di non seguire lo schema di una difesa che gioca sull’impietosire, “non vuole destare la massima considerazione trascinando in tribunale figlioli, congiunti o amici”. Suo intento è dire il vero: “voi da me non udrete altra cosa che la verità” “ho la convinzione di non dire nulla che non sia giusto” “chi giudica ha il dovere di badare non al modo di parlare ma se le cose dette sono giuste”.
Qualcuno ha messo le mani davanti: “State attenti o giudici a non lasciarvi trarre inganno da Socrate, abilissimo parlatore!” Forse che dire la verità è preoccupante? Oppure qualcuno vuol vedere come si comporta Socrate “messo a nudo”, lui definito dall’oracolo di Delfi come il migliore degli uomini. Lo saprà dimostrare? Si sa che gli uomini sostengono le proprie idee “a meno che …”, o come canta Iannacci “onesti fino ad un certo punto”.
“Io come un tafano ho cercato di pungolarvi, dal dio posto ai fianchi della città”, definita cavallo di buona razza ma un poco tardo e bisognoso di essere stimolato. “Non sarà facile trovare un altro al pari di me”. Lui era accusato di essere cattivo maestro, corruttore di giovani. Corrompere nel senso di rendere peggiori?
“Io ho sempre cercato di distogliervi dal darvi pensiero alle ricchezze, dalla brama di ammassarne quanto più possibile, e vi ho ammonito di astenervi dal desiderio di fama e onori”. Ben consapevole che il vizio è male, “dovendo scegliere mi attengo alla giustizia”. “A ciò è importante badare: se si opera il giusto o l’ingiusto, se uno compie azioni di onesto e valoroso uomo o azioni di vile e malvagio.”
L’accusa di blasfemia? “si dice che Socrate specula sulle cose celesti, investiga i segreti di sottoterra, non riconosce gli dei”, dipinto da Aristofane come filosofo sospeso in aria, a cianciare di sciocchezze. Sorate non credeva agli dei lussuriosi o buontemponi, gelosi o vendicativi, ma non era il solo. “Il dio non è vendicatore, Dio è il Bene”. “Il dio mi ha ordinato di vivere filosofando, adoperandomi di conoscere me stesso e gli altri”.
Socrate teme la morte spirituale, “che è, o cittadini, di credere di essere sapienti e non esserlo”. “Io non so nulla di preciso delle cose dell’Ade e neanche presumo di sapere”. Socrate è però certo: “o Ateniesi, io vi sono obbligato e vi amo, ma obbedirò piuttosto al dio che a voi”.
Racconta di quell’oracolo di Delfi Cherofonte che un giorno andò a Delfi e domandò; e la Pizia rispose che più sapiente di Socrate non c’era nessuno. “Cherofonte non può qui testimoniare perché è morto ma può farlo il fratello che è presente al processo”.
Socrate si è sempre chiesto cosa significasse quel responso e “si mise a cercare un sapiente, uno più sapiente di lui, anche tra i politici. Cercò di ragionare con chi si reputava o altri reputavano sapiente”. Si accorse che non lo erano come “i poeti che dicono molte cose e belle ma non sanno niente di ciò che dicono”. Questo gli suscitò rancore. Socrate non possedeva il sapere ma offriva un metodo per ottenere la sapienza. Il verdetto fu pronunciato: “colpevole!”.
Si passò a discutere la pena. Meleto, che era l’accusatore, chiese la morte. E lui, Socrate, cosa chiede? “Un premio chiedo, come si addice a un uomo che è povero e benefattore, avendo agito, o Ateniesi, per vostra istruzione”, “che sia nutrito a spese della polis!”. Fu condannato a bere la cicuta. La sua autodifesa aveva indisposto l’Assemblea e i colpevolisti aumentarono. La sentenza avrebbe dovuta essere eseguita lo stesso giorno. Si attese un mese, finché la nave rituale, partita dal porto per Delfi a rendere omaggio ad Apollo dopo il voto di Teseo, tornasse.
“Quando il carceriere gli presentò la tazza della cicuta egli la prese con volto sereno” suscitando la meraviglia dell’uomo abituato a ben altri atteggiamenti da parte dei condannati: “se la prendono sempre con me” borbottava il carceriere. Ignorante come i giudici che lo hanno condannato, “incolpevoli perché ignoranti”. Le ultime sue parole: “Ecco, è l’ora di andare. Io a morire voi a vivere. Chi per il meglio è oscuro a tutti, non per il dio”. Socrate non fu capito. Fu fallimento? Non secondo Platone che scrisse questa Apologia e quello che seguì, i Dialoghi, le Leggi, la Repubblica. Compito difficile è quello del filosofo. Ma c’è l’esempio di Socrate.
Calcio, Noesis 2024, 6 dicembre 2024