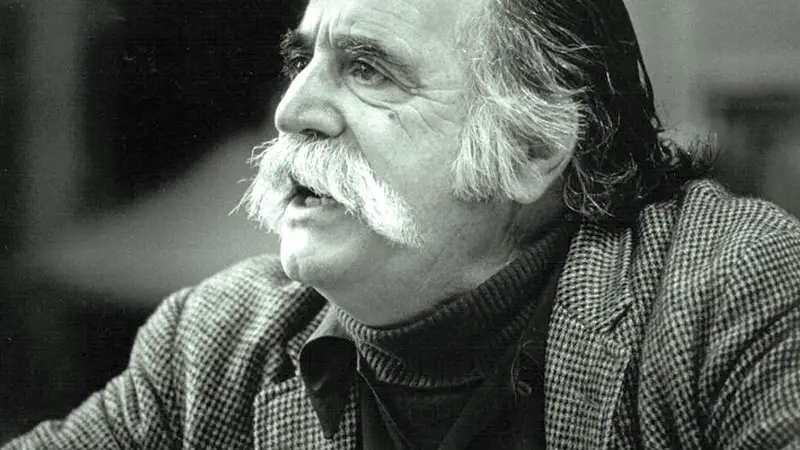Ho scoperto William Saroyan sfogliando un libro suo ad uso scolastico, In bicicletta a Beverly Hills, rimediato da una di quelle casucce dove si lasciano libri usati per salvarli dalla discarica. Una riflessione sulla propria vita, in semplicità e essenzialità di scrittura, memoria acuta la sua, da cui sa trarre pepite d’oro.
Nato a Fresno in California. “Mio padre non c’era la notte in cui venni al mondo. Volle che mi chiamassi William in onore del suo miglior amico, appena morto, che era un pastore presbiteriano.” Anche suo padre era predicatore, ma non trovava una chiesa che lo accogliesse. In quel momento lavorava come vignaiolo, venti chilometri lontano. “Se avessi potuto scegliere avrei scelto il nome di mio zio, Aram. Il suo dinamismo e il suo umorismo fecero presa su me. Aram era il nome prediletto degli Armeni. Chiamai Aram mio figlio; che almeno lui lo portasse! Aram si chiamava un poeta che io vidi a Fresno sempre con un libro sotto il braccio, senza mai affrettarsi, per poco, poi scomparve”.
Americano di nascita ma armeno nelle ossa. Al cugino un giorno chiesero di che famiglia fosse. “Americano” rispose. Lui lo riprese: “Dovevi dirgli che sei armeno”. E l’altro: “No, io non sono armeno; ho litigato ieri sera con mio padre e sono scappato di casa”. Salvo il giorno dopo dirgli: “Sono di nuovo armeno, ho fatto pace con mio padre”. Descrive la sua casa: “una mezza dozzina di sedie di bambù, due poltrone a dondolo, la tavola rotonda, il divano fatto con tre cassette di mele e un asse ricoperto di un rozzo panno a scacchi di Bitlis, con i materassi imbottiti di lana di pecore d’Armenia”.
Non conobbe il padre. Presto si ritrovò in orfanatrofio. “Tedioso il posto, dove non mi sentivo né potevo o volevo sentirmi a casa, in un artificioso sistema di leggi e regole imposte, tutto regolato secondo un orario”. La noia fu un tormento dell’infanzia fin da quando si separò dalla madre nella sala d’aspetto. Come con quel giocattolo meccanico di latta in un minuscolo palcoscenico pure di latta, il ballerino negro: “caricata la molla il negretto si metteva a ballare”. Bambino spensierato? Mica tanto: “Ho avuto la sensazione che la mia vita poteva finire da un momento all’altro. Un mio compagno finì sotto un camion. E facevamo la stessa strada per andare a scuola. E’ in cielo! dicevano, ma quel cielo lì non mi sembrava allegro”.
Ricorda Sammy, il primo amico. “Forse più vecchio di me che non avevo di molto superato i tre anni. Orfano di un genitore o di entrambi, era nella mia stessa camera con una mezza dozzina di altri bambini. Andavamo ovunque insieme. Una volta aizzati dai più grandi venimmo alle mani, ce le suonammo di santa ragione, poi smettemmo a un tratto e scoppiammo in lagrime. Tornammo subito amici”. “All’orfanatrofio ci insegnavano che i ragazzi che non erano buoni sarebbero bruciati per l’eternità nell’inferno. L’intenzione era di indurre i ragazzi a essere buoni. Non credo che la paura possa indurre alla bontà o far diverso qualcuno”.
Presto si mise a vendere giornali, come suo fratello per racimolare qualche soldo per la famiglia. “Ad un concorso scolastico, Scrivi al sindaco per indurlo a visitare la scuola. Vinsi e il sindaco venne a trovarci. La maestra mi trattenne dopo la scuola non in castigo ma per dirmi che dovevo proseguire gli studi”. “Lavorai come strillone nel circo. Alle fiere vendevo gazzose, alla festa dell’uva bandierine. Più che per i soldi era una sfida. In famiglia avevamo bisogno di soldi, ma ritenevo importante fare qualcosa. La madre di mia madre mi incitava a prendere la vita come un gairot che in parole povere significava “affrontare il mondo con mattutina solerzia, con metodo, gusto, zelo, destrezza”.
“Prima dei sedici anni ebbi non so quante biciclette. Non ho idea che fine hanno fatto. Ricordo soltanto che pedalavo con tanta foga che finivano per sfasciarsi. Sempre irrequieto, pedalavo, non mi stancavo mai. Mio fratello un giorno mi disse perché non mi fermavo: Vai, vai pure. Non uscirò mai più con te”.
Il suo pallino era eccellere, o almeno tentare di farlo. Ero impaziente di riuscire a fare qualcosa. Perché avevo fretta? non saprei. Forse per il fatto di non sapere con esattezza quanto tempo avevo da vivere”. Eccellere ma come? “Ricavare oggetti dalla pietra? Esaminavo attentamente la forma dei sassi. Ma quelle cose non erano uscite dalle mie mani. La carta? Con le matite colorate ne avevo dipinte di cose. La musica? Occorreva un pianoforte e poi il maestro. Per scrivere tutto ciò che ci vuole è la carta e una matita. Una cosa scritta è scritta per sempre. Perciò farò lo scrittore, tanto più che venni a sapere che mio padre era stato uno scrittore. Quando ebbi una macchina da scrivere mi accorsi che le parole volevano uscire veloci. Volevo scrivere un libro, ma di fatto uscivano poche e goffe e mi prendeva una rabbia. ... Ero ostinato nello scrivere. Lo scrivere è una cosa in movimento, esercizio di immaginazione e di memoria negli sconfinati orizzonti nel campo del possibile. Sentivo il bisogno di idee. Nessuno ne aveva di nuove da dividere con me. Nessuno interessato ad altro che a far quattrini, anche se ci voleva abilità nel saper far quattrini; perché c’erano i falliti. Avevo fastidio della povertà spirituale. Avevo bisogno di idee, e mi sono venute scrivendo“.
La sua scuola è stata la strada. “Ci sono le persone che amano il mare, quelle che amano i monti inaccessibili dove nessuno o chi hanno posato il piede. Io amo le strade. Strade mie, strade in cui ho camminato, che ho conosciuto e non posso dimenticare. Non è stato solo un camminare, ho anche corso, vi ho sostato. Questa è la mia vita. Ho visto gli altri che camminavano, la maggior parte una volta sola. La prima strada, l’ultima, quella intermedia, sono uguali, tutte insieme fanno il mondo, dove ho vissuto e vivo. Dovunque vivessi scendevo e vivevo nelle vie. Credo si tratti d’amore del mondo, amore della gente, perché il mondo e la gente si scoprono insieme. E’ nelle vie che il mio amore è più intenso, nel loro volto e nel volto delle folle. L’amore delle strade mi fa intuire la profondità del mio amore per Dio. Il cammino della gente si arresta, le strade rimangono. E così i libri“.
Scrivere ma da dove cominciare? “Avevo in me le più grandi verità da raccontare. Non è importante da dove si comincia. L’importante è adattarsi alla verità che non è altro che un uomo”. Lo scrittore si crea in definitiva una famiglia, una patria e io credo di aver creato la famiglia Saroyan che compare un po’ in tutti i miei scritti”. Voleva un mucchio di cose, in definitiva una cosa sola. “Nello scrivere si può essere tutto e tutti. Mi dicevo: scriverò del sole del gioco della luce o di musica, anche di una nazione, cose non nuove ma viste con occhi nuovi.”
Il sudiciume dà fastidio e distrae, diceva. “Mi detti d’impegno per riportare un po’ d’ordine intorno. Ma era un lavoro che non aveva mai fine. Come nel cortile di casa le erbacce si moltiplicavano per quanto si accanisse a sradicarle”. Anche nella sua vita c’era disordine: problemi di alcolismo, manie per il gioco, una vita sentimentale travagliata. Ce l’aveva fatta finalmente. Era diventato scrittore. Erano arrivati i soldi da redazioni e case editrici “e senza l’aiuto di nessuno” diceva orgogliosamente. Era stata dura. “Guardami come vado diritto verso ogni cosa!”. “Verso il tramonto nacqui. Ero lì, con tutti, e li vidi, vidi dov’erano e chi erano, e dov’erano loro ero io, chi erano loro ero io”. Morì all’alba del 18 maggio 1981, a 72 anni, per cancro alla prostata.
Saroyan parla al cuore, le sue parole ti entrano dentro perché sono vere. Portano aria fresca, lo scampanellio della chiesa in festa, il profumo dei fiori di strada. “Il fatto è che succedono un sacco di cose ogni giorno, ogni notte, e mi piace raccontarle”. Il necrologio se lo scrisse lui: “Naturalmente sapevo che gli uomini devono morire ma pensavo che per me avrebbero fatto un’eccezione. E adesso?”